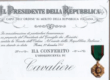di RENATO BONA
BELLUNO L’Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali guidato dal prof. don Sergio Sacco ha dato alle stampe (tipografia Piave) per conto del Comune di Sedico e della Biblioteca civica, era il marzio 1986, il prezioso volume (serie Quaderni) “Ricordando”, che propone con dovizia di particolari e numerose, bellissime fotografie, la storia e appunto immagini datate e per questo ancor più apprezzabili, del comune di Sedico. Artefice del capitolo”Aspetto economici e culturali nel tessuto sociale di Sedico” Gianni De Vecchi, un autentico personaggio, si è occupato anche di “Le cave di pietre molari” che erano situate parte nel comune di Sedico e parte in quello di Belluno. E la cui scoperta nelle località Valdantre (le cave più antiche e diroccate), Costalunga, Narda, Bez, Collungo del comune di Belluno e Conch di Libàno in quello di Sedico “si può senza dubbio collocare in tempi antichissimi”. In proposito De Vecchi precisava che “Solo basandosi sulla lunghezza delle gallerie scavate (con sistemi manuali fino a 30-35 anni fa) possiamo datare di molti secoli l’inizio di tale attività estrattiva”. Non manca, considerata la meticolosità dell’autore, un riferimento storico: “In molti film storici, negli antichi castelli, si vede spesso la mola ad acqua che serviva ad affilare le armi bianche; queste mole non potevano che provenire dalle nostre cave dal momento che, in Italia, gli unici giacimenti (di questo materiale) si trovavano nel Bellunese”. Ed è vero che molto più tardi vennero aperte cave negli Appennini e nelle valli vicentine del Pasubio, ma le mole estratte erano di qualità scadente “e quindi le bellunesi furono sempre preferite”. Ancora De Vecchi a rammentare che la prima cava che la tradizione ricordi fu a cielo aperto e sarebbe stata sfruttata da antichi romani saliti fin quassù coi carri trainati da buoi a caricare le mole. Ma la pietra di buona qualità era solo quella del sottosuolo e giocoforza si dovettero scavare gallerie per trovare una “vena” ottima, dell’altezza anche di 3-4 metri. Come che sia, l’estrazione delle pietre molari nelle cave di Bolzano Bellunese, Tisoi e Libàno è stata tra le più antiche “industrie” bellunesi, “favorita anche dalla vicinanza con Fisterre di Belluno dove si fabbricavano rinomate lance e spade) e l’arte dei ‘molàs’ (cavatori di pietre molari con lavoro stagionale) si tramandò per generazioni”. Nel 1800 le cave davano lavoro ad un’ottantina di persone. Nel 1867 erano occupati una settantina di “molàs” mentre nel 1891 le cave in esercizio erano 17 e le persone occupate per 150 giornate annue erano 85, diciotto delle quali di età inferiore ai 15 anni. Fin verso il 1935 i “molàs” erano artigiani che cavavano in proprio la pietra e vendevano il prodotto finito ai commercianti (ricordati nel 1870 Fant Alessandro e Da Rold Giuseppe e fratelli) quindi direttamente ai clienti avendo costituito una cooperativa fra produttori, con sede a Tisoi. Successivamente, 1946, la Fant Giacomo ottenne la concessione le cave ad eccezione di poche a Libàno, sfruttate dalla società “Arenaria” che nel 1937-39 aveva alle dipendenze 120 “molàs” escavatori, costruttori e tornitori. Il lavoro risultava malsano e molti contraevano la silicosi (“pusiera”) a causa della polvere di silicio che si formava durante la lavorazione, interamente manuale e che richiedeva notevole esperienza visto che i blocchi dovevano essere tagliati secondo il piano della “vena”. Descritte le varie fasi della lavorazione, spiega che con rapidi colpi venivano fatti cadere i blocchi o la lastra, 8 x 4 metri, della “tajada”, dello spessore tra i 22 ed i 50 centimetri, che venivano quindi tagliati nelle misure desiderate, caricati sul “car mat”, un tavolato da un metro per 1,70 che scorreva su due rulli di legno per essere trainato col suo carico all’aperto, grazie ad un argano che per molto tempo venne azionato manualmente! Solo negli ultimi vent’anni di attività “gli attrezzi rudimentali fino ad allora usati vennero sostituiti quasi del tutto con demolitori ad aria compressa per lo scavo in galleria, dal filo elicoidale per il taglio delle lastre e dai torni per la finitura delle mole all’esterno; ciò comportò la riduzione della manodopera, i costi di produzione ed il rischio di malattie professionali”. La storia volge quasi al termine: De Vecchi ricorda che negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale l’attività della ditta Fant Giacomo & Figli conobbe una notevole espansione, occupando fino a 150 operai con ciclo di lavorazione stagionale. Le pietre molari erano prevalentemente vendute ai consorzi agrari, alle officine meccaniche, ai negozi di ferramenta, agli stabilimenti siderurgici come “Cogne” in Val d’Aosta, alle coltellerie di Maniago e sui mercati esteri: Cecoslovacchia, Svezia, Medio Oriente, Egitto, Iran Iraq. Ma… agli alti costi di produzione conseguiva la vendita delle mole naturali a prezzi di gran lunga superiori a quelli delle mole artificiali e ciò determinò la crisi di questa attività millenaria che registrò nel 1963 la fine definitiva delle cave “pur nascondendo al loro interno ancora enormi quantità di materiale”. La conclusione: “Basterebbe trovare un metodo di estrazione e lavorazione a basso costo: le richieste di mole non mancherebbero. Le mole naturali hanno infatti pregi che quelle artificiali non possiedono. Finiscono così i ‘molàs’, questa stirpe che conosceva alla perfezione l’arte, affinata nei secoli, di cavare la pietra migliore per fare le mole. Ora, le cave sono adibite a fungaie”. NELLE FOTO (riproduzioni dal libro: “Ricordando. Storie e immagini del comune di Sedico”): una vecchia cava di pietre molari: si vedono i “molàs” davanti agli ingressi delle gallerie di scavo e il cantiere esterno, con mole già finite, altre in lavorazione e pezzi squadrati appena usciti dalle cave; anno 1930: un carico di mole del diametro di 150 centimetri, in partenza per Maniago, dove servivano alle fabbriche di coltellerie ed attrezzi agricoli; uno scorcio di Libàno di Sedico, paese dove si estraevano mole di qualità.