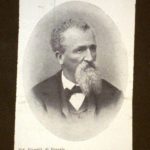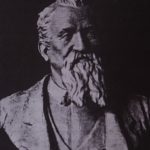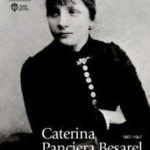di RENATO BONA
Il 29 luglio del 1829, centonovanta anni or sono, veniva alla luce ad Astragal di Forno di Zoldo, in provincia di Belluno, Valentino Panciera detto Besarel, figlio di Giovanni Battista, intagliatore e decoratore, e di Caterina Cordella, zoldana di Goima. La libera enciclopedia Wikipedia ricorda che Besarèl “è un soprannome di origine popolare usato per distinguere la famiglia dell’artista da altri ceppi omonimi, ma ha finito per assumere il predominio persino sul cognome, tanto che anche nel mondo artistico è conosciuto semplicemente come Valentino Besarel. Ultima rappresentante dei Panciera Besarel è stata la figlia di Valentino, Caterina, scomparsa nel 1947”. E aggiunge: “I Besarel erano dediti da generazioni alla scultura in legno: intagliatori erano stati il bisnonno Valentino (1747-1811), allievo di Giampaolo Gamba “Zampòl” e discepolo ideale del maestro Andrea Brustolon, il nonno Giovanni (1778-1842) e anche il padre Giovanni Battista (1801-1873); quest’ultimo aveva conseguito una certa fama locale lasciando opere in varie chiese dello Zoldano”. Ancora Wikipedia: “Nonostante ciò, la famiglia versava in condizioni di povertà, sicché Valentino non poté avere un’istruzione regolare. Ricevette una prima formazione nella bottega paterna, cui si aggiunse, agli inizi degli anni 1840, una breve frequentazione della scuola del disegnatore bellunese Antonio Federici. La svolta gli venne dall’incontro con Giuseppe Segusini, il quale lo vide all’opera mentre, al seguito del padre, decorava la chiesa arcidiaconale di Agordo. Grazie all’architetto feltrino ebbe modo di frequentare l’Accademia di Venezia dal 1853 al 1855, sebbene non fosse riuscito a terminare gli studi”. Le prime opere autonome, commissionategli sempre mediante il Segusini, furono i santi Pietro e Paolo per l’altare maggiore della parrocchiale di Tiser e i Quattro Evangelisti per la Cattedrale di Belluno (1855-1856). Besarel operò a lungo nella terra d’origine prima di trasferirsi, anni sessanta, a Venezia dove ebbe fama internazionale e divenne il fornitore ufficiale delle monarchie europee, anche se per un infortunio perse quattro dita della mano destra (a tale proposito, nel libro di Paolo Conte e Marco Perale “90 profili” edito da L’Amico del Popolo nel 1999, si rammenta che dopo l’incidente del 2 marzo 1885: “tra i tanti che gli telegrafarono ci fu la regina Margherita, assidua frequentatrice del suo studio e per la quale aveva scolpito un tavolo portagioielli. Dalla disgrazia si riprese costruendosi scalpelli e attrezzi adatti a lavorare nonostante la menomazione”. Coinvolse nella sua passione artistica i familiari e soprattutto la figlia Caterina. Massiccia e pregevole la presenza di suoi lavori in chiese e palazzi nel Bellunese (solo per citarne alcuni: la chiesa di Vigo di Cadore con la Pala del Gesù, il famoso tabernacolo nella chiesa di San Rocco nel capoluogo, il rosone in terracotta raffigurante il Battesimo di san Giovanni Battista nell’arcipretale di Canale d’Agordo; la celebre Madonna del Rosario nell’arcidiaconale di Agordo; Madonna del Rosario per la parrocchiale di Ospitale di Cadore e Madonna di Loreto per la chiesa di Santa Maria di Loreto di Feltre; la decorazione del soffitto di due sale della Magnifica Comunità di Pieve di Cadore, dove inserì 32 busti di illustri cadorini. All’inizio degli anni Ottanta realizzò per l’avvocato torinese Antonio Borgogna una gigantesca Apoteosi di Vittorio Emanuele II. Il sito treccani.it rammenta a sua volta che il nostro “… Nel 1858 sposò la conterranea Maria Fontanella, dalla quale ebbe sei figlie: Elisabetta (1859), Giovanna (1862), Caterina (1867) e altre tre morte in tenera età. La primogenita Elisabetta sposò a Venezia Antonio Casal, originario della Val di Zoldo e titolare di un importante cantiere per piccole imbarcazioni, con il quale Valentino collaborò a lungo. Caterina, ultimogenita, fu invece avviata agli studi artistici e assunse ruoli importanti nell’atelier del padre…”. Ancora su Valentino: “Risale al 1861 la prima partecipazione a una mostra di rilevanza nazionale: insieme al fratello Francesco si recò infatti a Firenze per la I Esposizione nazionale, dove i due ottennero una medaglia e un riconoscimento in denaro presentando una statua e un rilievo della Vergine e soprattutto una grande cornice ornamentale intitolata Fratellanza italiana: composta da una serie di paffuti amorini a tutto tondo che danzano tenendosi per mano, l’opera colpì la critica e la giuria per il vertiginoso virtuosismo dell’esecuzione. Il successo di quell’esperienza, unito alla consapevolezza delle possibilità che gli offriva la propria capacità tecnica, indirizzò in seguito Valentino verso l’intaglio decorativo di gusto neobarocco, sulle orme dell’illustre conterraneo Andrea Brustolon, del quale fu ben presto considerato una sorta di erede spirituale”. Concludiamo questa rivisitazione di Valentino Panciera Besarel ricordando con il sito dell’Associazione bellunesi nel mondo che nel marzo del 2014, col sostegno della Fondazione Angelini, nel mezzanino del Museo bellunese era stato allestito un percorso dedicato a Caterina Panciera Besarel, figlia di Valentino, artista e imprenditrice della Val di Zoldo a Venezia.
NELLE FOTO (Renato Bona, Wikipedia, Museoborgogna, Dizionario friulani, Google): Valentino Panciera Besarel; l’artista nel busto opera della figlia; il paese natale di Astragal; il Rosone del 1859 raffigurante Gesù con il Battista, sulla facciata dell’arcipretale di Canale d’Agordo; il Monumento ad Andrea Brustolon, a Dont di Zoldo; la Madonna del Rosario con il Bimbo e due angeli, scultura lignea della chiesa di Tricesimo; la via che gli è stata dedicata a Belluno; la figlia Caterina; il tabernacolo della chiesa di San Rocco; statue del Duomo bellunese; l’abside di Tiser coi santi Pietro e Paolo.